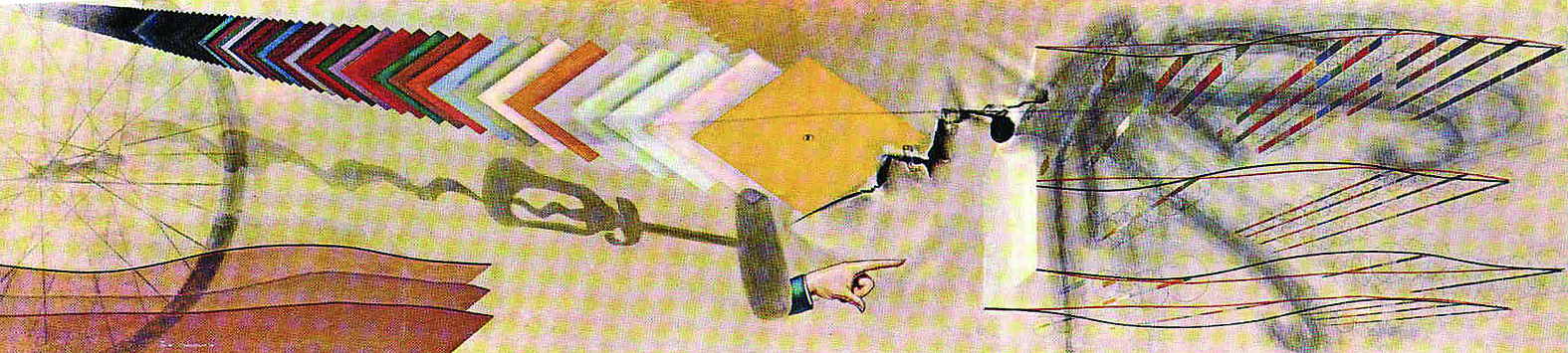La fotografia come ready-made – il ready-made come fotografia
Introduzione
Vorrei iniziare la mia relazione con un’immagine di Baudelaire che dipinge il poeta moderno come uno straccivendolo: “Tutto ciò che la grande città ha gettato via, tutto ciò che ha perso, tutto ciò che ha disprezzato, tutto ciò che ha schiacciato sotto i suoi piedi, egli lo cataloga e lo raccoglie… Egli classifica le cose e le sceglie con accortezza; egli accumula, come un avaro che custodisce un tesoro, i rifiuti che assumeranno la forma di oggetti utili o gratificanti tra le fauci della dea dell’industria.” (1)
La metafora di Baudelaire ci catapulta, infatti, direttamente al nocciolo del problema: la domanda se sia possibile sostenere che la fotografia è un ready-made o meno. Affiorano, fin da subito, problematiche centrali relative a entrambi gli ambiti: l’immagine del flâneur che percorre le strade abbandonandosi al caso e che, guidato dall’inconscio, sceglie con cura tra gli oggetti trovati e li raccoglie con un gesto istantaneo, è per noi significativa. Egli, dopo averli raccolti, infatti, li classifica e offre loro una nuova esistenza, dandogli un altro punto di vista, un nuovo pensiero, così da valorizzarli in modo inedito, mutando il loro uso e quindi il loro significato.
Questo procedimento analitico – a partire da materiali empirici, “trovati” e scelti, apparentemente a caso e successivamente appropriati e sintetizzati in nuovi snodi di significato – vale sia per la fotografia, sia per il ready-made. L’immagine di Baudelaire riassume così un meccanismo della produzione culturale della modernità, che si farà strada nella contemporaneità, dopo la folgorante entrata in scena del ready-made duchampiano. Basti pensare alla produzione surrealista, che sposta oggetti preesistenti da un contesto all’altro, li abbinano tra di loro o con termini a loro estranei e crea analogie tra significati, che provengono da ambiti differenti. Oppure la scia di chi colleziona delle citazioni, già iniziata da Walter Benjamin, che custodiva frasi raccolte come tesori preziosi. Questa scia ci porta nella produzione artistica postmoderna, basata su un gioco autoreferenziale di rimandi e su espliciti richiami del passato o presente artistico o sociale. Questi elementi citati, rimessi in scena modificati e in contesti diversi, mutano di espressione e di senso. Come ad esempio Andy Warhol, che riproduce le icone dell’era del consumo, lanciando un grido pubblicitario dell’immaginario, prodotto dalla società di massa. Oppure Thomas Ruff, che estrae delle fotografie dai giornali, le ingrandisce e togliendo loro la didascalia, le isola dal loro valore informativo originario, trasformandole in icone mute.
La mia è, dunque, una ricerca che, partendo da una preoccupazione e una pratica personale, vuole da un lato approfondire una comparazione strutturale, e dall’altro una comparazione degli elementi concreti, come sostegno, conferma o contraddizione della tesi iniziale.
Sono consapevole che i due oggetti comparati in verità non sono equiparabili, poiché non appartengono alla stessa specie. La fotografia è, in primis, un mezzo, uno strumento di riproduzione e di comunicazione, con una forte prevalenza del lato tecnico e un’importanza schiacciante nel funzionamento della società d’informazione di massa contemporanea. La fotografia ha alle spalle una storia lunga 170 anni, in cui si sono succedute numerose correnti teoriche, moltissimi autori, altrettante espressioni e quasi infinite possibilità di uso e di applicazione, sia a livello tecnico e visivo, sia a livello di utilizzo sociale. La fotografia è una rappresentazione bidimensionale, con un rapporto diretto e controverso con il reale.
I ready-made sono, invece, una creazione di un singolo artista: Marcel Duchamp (1887-1968). Secondo alcune fonti ne esistono in totale 10 o 12, secondo altre 30 o 35. Si tratta dunque di tre manciate di opere d’arte, limitate dall’artista stesso nel numero e nel tempo. I ready-made sono nati tra il 1913 (la ruota di bicicletta) e il 1923, quindi in un arco di 10 anni. Il ready-made è, al contrario della fotografia, un oggetto tridimensionale dalla difficile definizione: già solo chiamandolo “rappresentazione”, infatti, rischiamo di precipitare in problematiche interpretative complesse.
Il paragone fra due oggetti così diversi nel loro aspetto materiale, nella loro dimensione ed estensione spaziale, nel loro significato, uso e storia, necessita un se pur minimo comune denominatore: questo lo si potrebbe trovare, se si guardasse ai due oggetti come a due linguaggi a sé stanti, facendo un confronto fra meccanismi strutturali e produttivi, indagando atteggiamenti e procedure e analizzando gli elementi costituenti e i loro funzionamenti.
Il ready-made e l’universo di Marcel Duchamp
La mossa del ready-made, dell’opera “già pronta”, ha messo in crisi profondamente i valori e le premesse allora vigenti nell’arte: l’abilità manuale, la rappresentazione, lo statuto dell’autore, l’originalità e l’unicità. L’operazione concettuale, apparentemente semplice, non va pertanto vista isolata dall’universo globale nell’opera di Marcel Duchamp, ma va letta nel contesto generale di rimandi verbali, all’interno di una rete ironica di allusioni, di associazioni tra vari significati e di analogie di senso, che portano da un’opera all’altra. L’operare di Duchamp si è rivelato di una tale complessità, che continua a porre quesiti irrisolti relativi alla sua comprensione. La difficoltà di decifrare la sua opera, fa parte della strategia dell’artista, che ha passato il resto della sua vita – quella successiva alla produzione dei ready-made – a giustificare il proprio gesto. Tuttavia le sue note – formulate in uno stile allegorico e criptico –, sono ancor più enigmatiche e intricate dell’opera stessa e non hanno prodotto altro effetto, che accrescere l’abisso del mistero invece che chiarirlo. Si può leggere l’opera di Duchamp come un giallo, nel quale l’investigatore rimane intrappolato nella ragnatela dell’autore, e più si muove per uscirne, più i fili si stringono. Tutt’ora non sappiamo se il labirinto di Duchamp è da intendersi nel suo senso originario, che porta verso un centro, oppure nel senso di un errare disperato senza via di uscita. Il commento lapidario di Duchamp è: “Non c’è soluzione, perché non c’è problema.”
La strategia ironica di seminare false tracce, si potrebbe interpretare come una strizzata d’occhio rivolta alla critica d’arte, caratterizzata da pretese assolutistiche di “decidere” che cosa sia un’opera d’arte e cosa no e con la sua esigenza di chiarire e spiegare in maniera definitiva tutte le opere. La pratica di Duchamp potrebbe allora indicare un tentativo di guidarci dolcemente verso un processo di interazione continua del fruitore con l’opera. Un invito a una sorta di “work in progress” dialogico, nel quale si dispiegano dei significati mutevoli in continuo sviluppo e intreccio, come in un “brain storming” senza fine. I significati dell’opera rimarrebbero così aperti e l’opera stessa non si concluderebbe mai in una forma fissa, immobile e chiusa.
Duchamp stesso ci dà un indizio in questo senso: “Ho fatto i ready-made senza intenzione, senza altra intenzione tranne di liberarmi del pensiero. Ogni ready-made è diverso. Non vi si trova nessun carattere comune, salvo che sono prefabbricati. Ciò che riguarda un riconoscere di un’idea conduttrice: no. L’indifferenza. L’indifferenza rispetto al gusto: né il gusto nel senso di una rappresentazione fotografica, né il gusto nel senso di una materia fatta bene.” e ancora: “I ready-made furono una attività intenzionale, in cui dimenticavo la mia meticolosità, una forma di liberazione di qualsiasi forma di programma.”
Nel 1917 Marcel Duchamp invia il suo ready-made “Fountain” alla “Society of Independent Artists” a New York per una mostra aperta a tutti. Si tratta di un orinatoio comprato in un negozio, ribaltato e firmato “R. Mutt, 1917”. L’opera viene ignorata e depositata in un angolo. In “The blind man” appare poco dopo un articolo anonimo, presumibilmente scritto dall’artista, che commenta quanto è avvenuto: “Se Mr. Mutt ha fabbricato la fontana con le proprie mani o no, non ha nessuna importanza. L’ha scelta. Ha preso un articolo ordinario della vita, lo ha innalzato in maniera che il suo significato d’uso sparisse dietro un nuovo titolo e punto di vista, ha creato un nuovo pensiero per questo oggetto.” (2)
Uno dei motivi del rifiuto è stato, certamente, la mancanza di volontà interpretativa e un malinteso dovuto a una lettura errata, che presupponeva un possibile utilizzo dell’oggetto. Il messaggio fu, dunque, interpretato come massima provocazione, dal retrogusto immorale: il museo come “Pissoir”.
Attraverso il semplice gesto di rigirare l’oggetto, ribadito anche dalla direzione della firma, esso perde, invece, la sua originaria funzionalità, diventando un’opera d’arte che, per definizione, deve essere inutile. L’oggetto di uso quotidiano, evince allora un nuovo significato, tramite la decontestualizzazione, l’isolamento dal suo uso ordinario e, infine, la sua successiva ricontestualizzazione nel mondo dell’arte. Si tratta, chiaramente, di un atto linguistico di rinominazione. L’oggetto muta da orinatoio a immagine, e da multiplo a originale. La riproduzione acquista statuto di unicità, e quindi di opera d’arte. Non più rappresentante di una classe di prodotti industriali, l’orinatoio diventa questo particolare oggetto in tutta la sua unicità.
Esaminando i contenuti concreti dei significati emessi, tutta l’opera di Duchamp si pone volontariamente a un livello di banalità e volgarità proprie della cultura “bassa” e popolare: mossa ironica, da intendersi come critica alla cultura cosiddetta “alta” e “seria”, ritenuta dall’artista eccessivamente pretenziosa. Il ready-made, con la sua presenza fisica immediata, rimanda all’idea di feticcio, di apprensione diretta dei sensi e fa riferimento alla macchina umana, a un corpo che produce escrezioni. Tutto l’universo del senso duchampiano è attraversato da un’ambivalenza sessuale e muove da una base autoritrattistica, in un gioco ambiguo di doppia identità tra Duchamp e il suo alter-ego femminile, Rrose Selavy, che – pronunciato in francese – significa “Eros c’est la vie”. L’artista iscrive, così, la vita intera in una cerchia di erotismo, ma non solo. “Eros” si può intendere platonicamente come un tendere continuo verso una conoscenza compiuta, mai raggiungibile nella vita terrestre, che così ci riporta al processo di un’opera aperta, in continuo dispiegamento dialogico-interpretativo con la sua controparte. Ciò spiega quanto detto prima: la ragione del carattere enigmatico delle opere.
L’ambivalenza sessuale traspare anche nella fontana: il suo corpo rovesciato oscilla ambiguamente tra contenuto e contenitore. Esso muta, mediante un riorientamento, a immagine di ricettacolo uterino, a bassoventre e a pene. Non è più l’uomo che spande acqua, ma al contrario le gocce cadono su di esso. I tentativi di analisi terminologiche avanzati ad esempio da Thomas Zaunschirm in “Bereites Mädchen, Ready-made” (3) non sono da prendere alla lettera come verità assolute o da intendersi come interpretazioni che fissano o dischiudono i significati, ma, come risposte all’invito dell’artista ad un gioco aperto di associazioni verbali. Zaunschirm sottolinea, ad esempio, l’affinità sonora tra “urinare” e “rovinare” (in francese uriner e ruiner), ed esplora i diversi significati della parola “Fountain” in inglese. Essa, infatti, oltre a fontana, significa anche “penna stilografica” e ciò ci riporta sull’asse linguistico delle operazioni duchampiane.
Anche nella firma “R. Mutt” si nascondono, secondo Zaunschirm, diversi rimandi linguistici: Mutt potrebbe ricordare la parola “mud” – che significa sporco – o “mutt” – che vuol dire stupido. Mentre R. – che sta per Richard – conterrebbe “rich” e “art”, oppure il significato francese di “richard”, ossia “riccone”. Inoltre R. Matt, pronunciato in inglese, alluderebbe a re matto, alias “scacco matto”.
In un’incisione del 1964, che raffigura un disegno del suo orinatoio, l’artista ha applicato alcune scritte come didascalie: UN ROBINET ORIGINAL REVOLUTIONNAIRE, in cui ha evidenziato in rosso le lettere, che formano la parola URINOIR. RENVOI MIRIORIQUE, che diventa RENVOI MIROIRIQUE, ossia “rinvio specchiante”, che si riferisce al principio di rappresentazione in quanto specchiamento della realtà e potrebbe intendere il quadro e la fotografia. Le parole rovesciate da RIO a ROI, da “fiume” a “re”, richiamano di nuovo il colare dell’acqua nella fontana e il re degli scacchi. L’ultima scritta, UN ROBINET QUI S’ARRETE DE COULER QUAND ON NE L’ECOUTE PAS, in cui sono evidenziate in rosso le lettere che formano la parola URINE, potrebbe alludere alla differenza tra funzionamento sessuale maschile e femminile: “un rubinetto che smette di colare” come parte maschile e “quando non lo si ascolta”, come parte femminile. Messe insieme ricreano la stessa identità sessuale ambivalente, come tra l’artista e il suo alter-ego femminile, e la frase potrebbe significare, per entrambe, che senza attenzione e interazione è impossibile che nasca alcuna scintilla di erotismo.
Mi limito di proposito all’interpretazione dettagliata di un solo ready-made, considerando il tempo e lo spazio ridotto di questa relazione. Questo esempio della fontana intende evidenziare il “meccanismo” di lettura anche per altri esempi. Come già sottolineato precedentemente, il lavoro interpretativo di tutte le opere duchampiane rappresenta un processo continuo e non concluso, dove ogni opera rimanda, con terminologie specifiche, alle altre. Come un tessuto autoreferenziale infinito o un gigantesco autoritratto costituito da rimandi interni.
Fotografia e ready-made: gli snodi comuni
Nel tentativo di stabilire se esiste una parentela tra il funzionamento della fotografia e quello del ready-made, ho trovato una varietà inaspettata di convergenze, di analogie e di meccanismi paragonabili, sia nella struttura e nella produzione, sia riguardo ai termini. Il mio operare procede in parte indagando il campo del ready-made nei termini posti dalle teorie della fotografia, in parte avanzando con un confronto diretto tra i due oggetti. Gli snodi comuni, che cercherò di sviluppare si possono riassumere in quattro tematiche: “il rapporto con il reale”, “il linguaggio”, “il rapporto con la pittura” e “l’originalità e la riproducibilità”. Un progetto certamente troppo ambizioso, per trovare uno sviluppo soddisfacente in questa sede: così la mia relazione si può considerare come uno schizzo, un tentativo “non finito”, un accenno e uno spunto per riflessioni ulteriori.
Il rapporto con il reale
La controversia sul rapporto della fotografia con la realtà sembra infinita e si colloca su una scala tra due poli: da un lato quello di copia esatta della realtà, dall’altro quello di assoluta irrealtà e artificio. Le due posizioni estreme trovano espressione nell’interpretazione del ruolo della macchina fotografica: per la prima, la macchina rappresenta un mezzo automatico, che opera da sola, detenendo un potere autonomo. Per l’altra, invece, essa si limita a essere uno strumento irrilevante, cosicché l’operazione si riduce all’atto del fotografo, che non solo si esprime con materiale trovato, ma che crea addirittura una nuova, propria realtà a sé stante.
Il “realismo ingenuo”, visione minoritaria nel panorama teoretico, si trova stranamente in Mc Luhan (4), che sostiene che la fotografia rispecchi autonomamente il mondo esterno, nonostante egli consideri che i mezzi tecnologici siano delle estensioni dei sensi umani, logicamente connessi ai processi percettivi e selettivi. Claudio Marra (5), invece, sottolinea che la fotografia è specularità assoluta e autenticità del reale, nonostante poi riconosca – in un altro scritto – l’intreccio del mezzo con meccanismi interpretativi. André Bazin (6) esaspera il realismo, identificando l’immagine con l’oggetto referente. L’immagine sarebbe l’oggetto stesso, acquisendo così lo statuto di modello.
Susan Sontag (7) spiega da dove proviene la confusione teorica dell’illusione di realisticità nella fotografia: il carattere rivelatorio viene presentato come realismo e le immagini usurpano la realtà, perché non sono solo immagini, ma anche impronta. Esse sono veritiere, perché assomigliano a qualcosa di reale e false, perché sono solo somiglianza.
Le posizioni, che negano alla fotografia qualsiasi legame con il reale, sono altrettanto rare di quelle del realismo assoluto. Massimo Cacciari (8), ad esempio, ritiene che la fotografia non sia duplicazione della realtà, ma rappresentazione della totale impossibilità della stessa duplicazione, e perciò esibizione di una nuova realtà, che solo in apparenza avrebbe i tratti della nostra. Penso, in realtà, che il filosofo usi toni provocatori e polemici per dire, in verità, che non ci può essere attività umana che non sia interpretazione. Di conseguenza, anche nel caso in cui sono implicati oggetti presi qua e là dalla realtà esterna, la specie umana non è in grado di produrre oggettività di alcun tipo.
Tra il bianco e il nero si trovano, tuttavia, molte sfumature di grigio: sono analisi che mediano non tanto tra le due posizioni viste come contraddittorie, quanto tra le due componenti intese come inerenti al mezzo fotografico stesso. La fotografia è considerata essere traccia fisica non della realtà intesa in quanto tale, ma di un frammento di realtà, il cui prelevamento presuppone una scelta, un punto di vista e quindi un’interpretazione. Le riflessioni intermedie considerano, sia il lato meccanico di pura copia fisica prodotta da raggi di luce e rivelata con mezzi chimici, sia il lato interpretativo da parte dell’operatore della macchina. Di conseguenza la fotografia è vista come tecnica capace di un’espressione linguistica, che crea un nuovo senso. Essa diventa così un mezzo di scrittura, con materiali prestati dal reale, tramite un atto percettivo e quindi selettivo.
Per Rosalind Krauss (9) la fotografia necessita un rapporto diretto con il referente, in quanto è impressione diretta e scambio tra due corpi in uno stesso luogo. Essa, tuttavia, cade in un paradosso: da un lato, la realtà è impressa, dall’altra è costituita in segno e diventa scrittura. La natura si ritrova strutturata e codificata, la macchina fotografica stessa strappa un’immagine dal tessuto del reale ed elimina il resto del mondo.
Susan Sontag (10) evidenzia come la dicotomia tra “vera espressione” e “registrazione fedele” corrisponde alla contrapposizione tra io e mondo. La fotografia offrirebbe un sistema unico di rivelazione, che ci mostra la realtà come non l’avevamo mai vista. La contrapposizione si dissolve considerando che il realismo fotografico non è ciò che realmente esiste, ma ciò che realmente percepiamo.
Dove si posiziona allora il ready-made nella scala appena tracciata tra il reale e la sua percezione, tra il mondo e l’io, tra la copia della realtà e l’interpretazione? Certamente, fermandosi alla prima apparenza, si potrebbe supporre analogamente al “realismo ingenuo”, che si tratti di oggetti del reale, rappresentanti diretti del mondo. Claudio Marra (11) – coerente alla sua posizione da realista riguardo alla fotografia – si convince che anche il ready-made sconvolge la logica del manufatto e che il suo realismo non deriva da un principio di articolazione linguistica, bensì che coincide con l’esistenza e il manifestarsi dell’oggetto. Come la fotografia, “l’objet trouvé” si ridurrebbe a una riproduzione del reale tale e quale e a una meccanicità ri-produttiva.
Penso che l’ingenuità di questa posizione stia nel fatto che questa si fermi al primo ingranaggio del meccanismo. Innegabilmente un ready-made è un oggetto della vita quotidiana e una fotografia contiene un’impronta del reale, ma ciò non significa che essi coincidano con la realtà. Come esprime bene Susan Sontag (12): “la vita non è fatta di particolari significanti, non è illuminata da un flash e non è fissata per sempre. La fotografia sì”.
Alla pretesa del realismo sfugge il seguito dell’operazione, la parte fondamentale, quella che mette mano sul reale, che trasforma i frammenti prelevati e, come sostiene Duchamp, dona loro un nuovo pensiero. Il senso nuovo si costituisce dapprima, tramite la scelta accurata dell’oggetto, e il suo isolamento dal contesto abituale, di seguito attraverso la sua evidenziazione con l’incorniciamento in un ambito differente. La cornice del ready-made è costituita dal piedistallo o dallo spazio espositivo. La cornice della fotografia invece dal foglio di carta, che delimita esattamente il frammento rilevato dalla macchina, ma scelto dal fotografo. Il fatto di estrarre una cosa dal suo contesto, già di per sé, ne modifica il senso. Ricollocarla, poi, in un altro contesto, lo muta ulteriormente. Ciò che vale per le immagini o per gli oggetti, vale ugualmente per uno scritto: basta togliere una frase da un testo e abbinarla a un’altra frase presa da un’altro testo e il significato cambia. Ogni scelta implica un punto di vista, e ogni punto di vista un’interpretazione e il senso di ogni singolo elemento, fotografia, oggetto industriale, proposizione che sia, si determina all’interno del contesto, nel quale si trova inserito.
La fotografia e il ready-made sono stati entrambi vittime di un malinteso: i due elementi, la porzione di realtà oggettiva e la componente interpretativa-espressiva, non sono da intendersi come due antitesi, che si escludono, e che richiedono una presa di posizione: al contrario sono parti integranti, che collaborano nella produzione di senso. Nella scala tra i due costituenti può variare la percentuale di ciascun elemento. Innumerevoli sono i modi e gli atteggiamenti per produrre fotografie e per posizionare e rinominare un “oggetto trovato”: il peso tra gli aspetti realistici e quelli interpretativi cambia a seconda della posizione del fotografo o dell’artista rispetto al reale e in base a quanto sia forte il suo impatto personale. Le sfumature tra lavori più o meno realistici e più o meno espressivi attraversano tutta la gamma.
L’operatore può tendere verso una minima implicazione personale e dare massimo rilievo alla situazione che incontra. Questo atteggiamento conduce al fotogiornalismo e con esso all’illusione di una presunta oggettività delle immagini. Illusione facile da smontare: basta vedere come la stessa foto, pubblicata in due giornali diversi, cambia senso mediante la sua diversa collocazione, il trattamento e la contestualizzazione testuale e grafica, che rispecchia il punto di vista politico della redazione.
D’altro canto, l’operatore può spingere a oltranza la sua espressione personale, senza per questo riuscire a far tacere la voce del mondo. Nonostante le innumerevoli possibilità di posizionamento nella scala, rimangono sempre attive entrambe le componenti e nessuna delle due può mai essere totalmente esclusa.
Il caso e la scelta
Chiarita la questione del realismo, vorrei esaminare più da vicino la costituzione del lato interpretativo sia nella fotografia, sia nel ready-made, analizzando, passo dopo passo, gli elementi del meccanismo fisico complessivo – il lato linguistico verrà trattato separatamente.
Lo straccivendolo o il flâneur che percorre le strade, abbandonandosi al caso e, guidato da una curiosità priva di presupposti, spinto da una necessità di trovare, senza sapere cosa, rappresenta l’animo del fotografo e dell’artista moderno e contemporaneo. Il mondo intero diventa per lui un gigantesco magazzino di materiali da scegliere, da prelevare e rinominare, per creare un oggetto, un’espressione, una poetica propria. Henri Cartier Bresson (13) lo esprime così: “Vagavo tutto il giorno per le strade, sentendomi molto teso e pronto a buttarmi, deciso a prendere in trappola la vita, a fermare la vita nell’atto in cui veniva vissuta.”
L’abbandono al caso, se da un lato implica un’apertura mentale, un accrescimento del ventaglio di possibilità all’interno del materiale empirico esistente, dall’altro porta, tuttavia, a una perdita di controllo momentanea, spesso applicata intenzionalmente sia dai fotografi, sia da Duchamp. Thomas Zaunschirm (14) conferma che la logica segreta dei ready-made sia il caso e che esso sia responsabile della diversità nell’opera duchampiana. Il caso non si ripete mai e la sua irriproducibilità, la sua rarità ed esclusività lo rende tanto prezioso per i fotografi, quanto per gli artisti, così da diventare un elemento primordiale nei metodi di produzione della modernità e della contemporaneità.
Lasciarsi guidare dal caso significa mettere fuori uso, coscientemente o no, l’intenzionalità e vincere la tendenza umana alla programmazione e all’ordine sistematico. La ragione sfida se stessa contro la propria inclinazione di procedere in griglie organizzate e apre le porte a elementi imprevedibili e istantanei. Marcel Duchamp (15) parla esplicitamente del suo bisogno di disinnescare il meccanismo intenzionale, per mettere fuori gioco la sua stessa natura meticolosa.
Il controllo perso durante il vagabondaggio attraverso il mondo viene ripreso in mano con piena efficacia nel momento in cui avviene la scelta dell’oggetto, nell’attimo in cui parte lo scatto. Il duplice movimento tra abbandono all’inconscio e ripresa di piena intenzionalità assomiglia a una zoomata avanti e indietro, a un tuffarsi, per poi distanziarsi. Se questo meccanismo da un lato garantisce una diversità massima, dall’altro prepara il terreno per un colpo preciso e mirato, privato ora da qualsivoglia casualità, che riguadagna il controllo razionale a pieno titolo. La perdita di controllo è condizione necessaria al suo esercizio rafforzato. Questo funzionamento assomiglia al gioco del gatto con il topo: il gatto finge di lasciare scappare il topo, per poi afferrarlo, riprendere il controllo e di nuovo lasciarlo andare per finta, fino al prossimo attacco.
Sia la fotografia che il ready-made sono figli della modernità, la quale coincide – secondo Roland Barthes (16) – “con l’era delle rivoluzioni, delle contestazioni, degli attentati, delle esplosioni, in poche parole delle impazienze, di tutto ciò che nega la maturazione”. Queste espressioni di impazienza e di discontinuità provocano sempre un intervento delle istituzioni statali, proporzionale alla forza delle contestazioni. Lo stato cerca di ristabilire il controllo, di solito con mezzi repressivi fisici, militari, o mentali, civili, tramite la limitazione della libertà d’espressione e dei diritti di partecipazione democratica.
Umberto Eco (17) lega l’idea di caso a quella di scelta: “la fotografia cerca di spremere il reale nella sua casualità e imprevedibilità, e invita a una reinterpretazione e ricostruzione dell’immediato… Il fotografo gira per la strada e individua accadimenti di indubbia suggestività. Da un lato li trova, inquadra, sceglie, dall’altro li costruisce, con angolatura, tipo di luce, ravvicinamento.”
Il momento della scelta rappresenta il punto decisivo e cruciale nella produzione della fotografia e del ready-made. Abbiamo visto come Duchamp spiega che non importa se Mr Mutt abbia fabbricato l’oggetto o no, ma l’unica cosa che conta è che l’abbia scelto. La scelta del fotografo si concretizza tramite il taglio di un frammento dal flusso continuo del tempo e dello spazio, ciò che implica un posizionamento fisico, la scelta di una distanza e di una direzione dello sguardo, ossia di una prospettiva. Rosalind Krauss18 evidenzia come il senso di un’immagine fotografica – quanto di un ready-made – sia costituito dalla scelta. Nella fotografia si costituisce tramite il taglio che trasforma alcuni segni naturali in segni culturali, per diventare scrittura. Nel ready-made il taglio è espresso dall’estrazione dell’oggetto dal suo contesto fisico e significativo abituale e dalla seguente ricollocazione in una nuova situazione.
L’appropriazione
Una volta individuato l’oggetto, esso va preso e posseduto. L’oggetto diventa preda e il viandante un cacciatore: per Wim Wenders (19) l’atto del fotografare è un atto di caccia. Il verbo scattare indica questa vicinanza, poiché vale sia per la macchina fotografica, sia per il fucile. Secondo Wenders, la fotografia crea un’immagine duplice: davanti questa mostra il suo oggetto, dietro, come controscatto, l’immagine di colui che fotografa, come silhouette del suo animo e della sua motivazione. Il controscatto corrisponde al contraccolpo del cacciatore. Il paragone della caccia evidenzia il legame tra scelta e appropriazione, che presuppone una mossa di sopraffazione. Anche Susan Sontag (20) definisce l’atto di fotografare come atto predatorio: “fotografare una persona equivale a violarla, trasformarla in oggetto, che può essere simbolicamente posseduto. Fotografare significa appropriarsi della cosa che si fotografa e la macchina fotografica è uno strumento per filtrare il mondo e trasformarlo in oggetto mentale.”
L’immediatezza e l’istantaneo
Fotografia e ready-made sono strettamente legati nella ricerca del viandante, nella precisa scelta, nell’appropriazione dell’“oggetto trovato”, e nel suo incorniciamento. La loro natura di immediatezza costituisce un ulteriore caratteristica comune. La velocità del mezzo fotografico, oggi accelerata dalle tecniche digitali, la sua capacità di catturare l’istante, di immobilizzare l’attimo e di estrarre, in un colpo secco, un pezzo di continuità spaziale e temporale, corrisponde al ritmo del ready-made nel momento dell’acquisizione dell’oggetto. Per Duchamp, l’istantaneità dell’azione nel ready-made è parte integrante del meccanismo e del senso dell’opera. Egli lo definisce così (21): “proiettando in un momento futuro (tal giorno, tal data, tal minuto) di iscrivere un ready-made. Il ready-made potrà poi essere cercato (con tutti i dettagli). La cosa importante allora è quindi questo orologismo, quest’istantanea, come un discorso pronunciato in occasione di una cosa qualsiasi ma alla tal ora. È una specie di appuntamento.”
Si tratta, dunque, di un appuntamento istantaneo che, tuttavia, deve essere ancora individuato, guidato dal caso e dall’inconscio. L’appuntamento si definirà in quell’istante preciso, in cui si rivelerà l’oggetto infine trovato. L’appuntamento si riferisce ugualmente all’idea di limitazione dei ready-made in tempo e numero, per evitare che diventino tic inflazionati e meccanismi infinitamente ripetibili. Un ready-made, come penso anche una fotografia, deve essere un appuntamento generato dal corso della vita, un momento istantaneo e unico, irripetibile e quindi prezioso. Come un punto di vista è sempre unico, così ogni scelta effettuata dal fotografo o dall’artista sarà unica e rappresenta una testimonianza di quell’istante preciso, in cui avviene quell’incontro fortunato. Così, l’aura benjaminiana, che circondava l’opera d’arte nella sua unicità, e che sembrava dissolta dai mezzi di riproduzione, invece forse riaffiora nella fotografia e nel ready-made in una forma diversa: l’aura dell’irripetibilità dell’istante.
L’inconscio individuale, sociale e tecnologico
L’esposizione al caso e l’apertura alla curiosità, analizzate in precedenza, appaiono come situazioni prive di guida. Ciò vale se si considera l’intenzionalità unicamente come atto di coscienza. Potremmo chiederci, tuttavia, se, sotto lo strato della coscienza, esista uno strato subconscio, capace di guidare lo straccivendolo nei suoi percorsi come un cane che guida un cieco. Il caso, allora, non sarebbe soltanto casuale, ma per fare effetto presuppone una disponibilità del soggetto ad accoglierlo. Secondo Franco Vaccari22, artista concettuale italiano, esistono tre tipi di inconscio, che lavorano in modo sotterraneo nella fotografia: l’inconscio individuale, l’inconscio sociale e l’inconscio tecnologico. L’inconscio individuale del fotografo o dell’artista corrisponde all’intuizione del soggetto nel vedere e nell’individuare delle situazioni particolari, che possono offrire del materiale a un ulteriore sviluppo poetico. Con l’inconscio sociale si intendono le convenzioni culturali, linguistiche, morali e sociali di una comunità, che permettono l’intento e la comunicazione tra gli individui. L’inconscio tecnologico, invece, è costituito da regole inerenti alla macchina, che strutturano la sua produzione. L’insieme delle regole funziona come inconscio. La fotografia, allora, si colloca entro sistemi linguistici propri in modo analogo alla parola. Un’immagine fotografica ha sempre un senso, anche in assenza di un atto cosciente dalla parte del soggetto, perché essa è un segno strutturato dall’inconscio tecnologico del mezzo fotografico, dell’inconscio sociale e individuale e funziona come vera e propria “scrittura automatica”.
Il primo a mettere in rapporto fotografia e inconscio fu Walter Benjamin (23), parlando di inconscio ottico: “Si capisce così come la natura che parla alla cinepresa sia diversa da quella che parla all’occhio. Diversa specialmente per il fatto che, al posto di uno spazio elaborato dalla coscienza, interviene uno spazio elaborato inconsciamente.” “…interviene la cinepresa con i suoi mezzi ausiliari, con il suo scendere e salire, con il suo interrompere e isolare, con il suo ampliare e contrarre il processo, col suo ingrandire e ridurre. Dall’inconscio ottico sappiamo qualcosa soltanto grazie ad essa, come dell’inconscio istintivo grazie alla psicoanalisi.”
L’inconscio ottico di Benjamin è, quindi, ciò che sfugge al soggetto a causa dei suoi limiti organici percettivi, ma che si rivela al mezzo, non attraverso un’operazione di strutturazione, ma di svelamento. I tre livelli di inconscio di Vaccari – e maggiormente quello meccanico dell’inconscio tecnologico –, sono, quindi, corresponsabili dello straniamento dell’immagine fotografica, rispetto alla visione naturale. La modificazione non si riduce soltanto al ribaltamento da tre a due dimensioni, all’inquadratura, al fuoco, al contrasto più o meno accentuato, ma, come indica il termine di inconscio ottico, vi intervengono distorsioni dalla parte della lente adoperata. Essa ci permette, appunto, di vedere delle cose mai viste in precedenza: piani vicinissimi zoomati e quindi strutture ingrandite o spazi larghissimi raccolti e distorti da una lente di grand-angolo.
La memoria e il tempo
(…) (testo completo vedi pdf da scaricare)
Il linguaggio
L’analogia tra la fotografia e il ready-made si delinea – come abbiamo visto – in una parentela procedurale e concettuale, dovuta a una serie di operazioni identiche: quella dell’implicazione del caso, della scelta, dell’appropriazione, della decontestualizzazione e della conseguente ricollocazione dell’oggetto. Sia la fotografia, sia l’oggetto acquistano un nuovo senso, tramite la loro ambientazione in un campo diverso, lo spazio artistico, con i suoi codici di lettura specifici. Già la matrice etimologica della parola “esporre” – da “ex-porre” – indica l’azione del porre fuori qualcosa da un determinato contesto, per acquisire una nuova rilevanza, in una diversa posizione. L’oggetto in tal caso si risemantizza, favorendo una fruizione estetica. Per Franco Vaccari (28) “non c’è differenza tra complessi industriali che producono oggetti e macchine fotografiche che producono immagini: il processo produttivo avviene obbedendo a codici che immettono l’oggetto finale entro uno spazio simbolico e di rappresentazione”.
Duchamp avvalora esplicitamente questo atto linguistico, ribaltando o modificando l’oggetto, e togliendogli il significato originario, legato al suo utilizzo: un’opera d’arte è per definizione privo di valore d’uso. Già Wittgenstein (29) identifica il valore d’uso con il significato: “Considera la proposizione come strumento e il suo senso come il suo uso.” La firma e la data applicate marcano ulteriormente il ready-made come opera d’arte. La rete di significati, i giochi di parole e i rimandi linguistici all’interno dell’opera complessiva, portano l’espressione duchampiana, inoltre, sul piano di un’arte primordialmente concettuale e linguistica. L’oggetto, allora, non si limita soltanto all’identità di opera d’arte in quanto tale, ma acquisisce statuto di proposizione all’interno di un discorso ampio e intricato.
Rosalind Krauss (30) individua il punto di conversione tra i due ambiti: “il parallelismo tra ready-made e fotografia è stabilita dal suo processo di produzione. Si tratta della trasposizione fisica di un oggetto dal continuum della realtà nella condizione fissa di un’immagine d’arte, tramite un momento di isolamento o selezione. In questo processo richiama ugualmente la funzione di “shifter”. Esso è un segno garantito dalla presenza esistenziale di esattamente questo oggetto. Si tratta di un significato senza significato istituito tramite i termini dell’indice.”
Rifacendosi a Charles Sanders Peirce, Rosalind Krauss (31) punta l’attenzione su un particolare di grande rilevanza: la sostanziale indicalità della fotografia e, come vedremo più avanti, l’evidenziazione e la ripresa consapevole di questo meccanismo nell’opera di Duchamp. Per Peirce esistono tre tipi di segni, che si differenziano nel loro rapporto con il referente: i simboli, le icone e gli indici. Nei simboli la relazione fra segno e referente si fa arbitrario, mentre nelle icone – ad esempio nei quadri – questa è marcata da una somiglianza. L’indice è il segno più aderente: esso è traccia e impronta diretta del referente, oppure il suo sintomo.
Il segno fotografico è condizionato dal suo rapporto fisico necessario con il referente. Il legame della traccia significante con la cosa che rappresenta è di essere stata fisicamente prodotta dal referente, come un’impressione diretta lasciata dai passi nella sabbia. Avevamo già visto in precedenza come l’indicalità della fotografia determina il suo rapporto necessario con il reale, ora vediamo come essa incide nella costituzione del segno e del significato. Anche Barthes (32) sottolinea la natura indicale del segno fotografico: “La fotografia si trova sempre all’estremità di quel gesto; essa dice: questo, è proprio questo, è esattamente così. La Fotografia non è mai altro che un canto alternato di “Guardi”, “Guarda”, essa addita un certo vis-à-vis e non può uscire da questo puro linguaggio deittico.”
La fotografia e il ready-made indicano l’oggetto, puntano il dito ed esclamano: guarda quello, è proprio questo, è stato esattamente così. Come spiega Rosalind Krauss (33), le parole “questo”, “quello”, “oggi”, “domani”, “qui”, “ora”, “io”, “tu” sono segni deittici e sono in sostanza segni vuoti, in attesa di essere specificati da una contiguità spaziale o temporale. Essi necessitano un inserimento in un determinato contesto e attendono di essere riferiti a un oggetto che conferisca loro un senso preciso. Sono segni indicali specifici, chiamati da Jakobson “shifters” o commutatori. Il loro dramma è che non possiedono un significato di per sé, ma devono essere rivolti a qualcosa per significare. In un dialogo, ad esempio, il significante delle parole “io” e “tu” cambia posizione, ogni tal volta che prende la parola l’altra persona e che, di conseguenza, cambia il referente.
Ciò fa pensare a quanto sia difficile l’acquisizione della comprensione dei commutatori. Anche Wittgenstein si chiede se i termini “quello” e “questo” si imparino come le parole denominatori, ad esempio “tavolo”, puntando sull’oggetto corrispondente. Evidentemente no: poiché l’oggetto designato non coincide con la parola, con cui si designa.
Si impara il significato delle parole mutanti, degli “shifters” con la pratica, allenandosi nel loro uso, finché si capisce che il loro significato non è fisso e legato alla parola, come nei termini, che designano un oggetto, ma flessibile e legato al referente, che muta seguendo il punto di vista di chi parla. Così la fotografia e il ready-made dimostrano che il linguaggio non ha un senso che gli è proprio e non esiste indipendentemente dal suo uso, dalla volontà di un locutore dato e da un contesto determinato.
L’indicalità e l’eco della fotografia nell’opera di Marcel Duchamp non si limitano alla funzione deittica dei ready-made, ma attraversano tutta la sua poetica, come trama strutturale e riflessiva. Ispirandosi al principio fotografico, egli analizza le condizioni indicali, cui questo mezzo ha sottoposto il mondo dell’arte. L’analisi della natura dell’indice, della funzione della traccia e del suo rapporto con la significazione si ritrova oltre che nei ready-made – in modo quasi più esplicito – in due opere eseguite con il mezzo della pittura e che, malgrado ciò, non funzionano come quadri, ma come fotografie: il “Grande Vetro” e “Tu m’”. L’interesse di Duchamp per il principio fotografico e indicale nasce dal suo atteggiamento anti-pittorico. Per l’artista concettuale, la pittura tradizionale si riduce a puro piacere “retinale” e a pasticcio “olfattore”. Per la mancanza di componenti riflessive e significative di quel mezzo, Duchamp se ne allontana e rivolge la sua attenzione a un arte, il cui compito è di “dare un nuovo pensiero” a un oggetto.
Rosalind Krauss (34) individua gli elementi indicali e fotografici in queste due opere maggiori, in un’indagine meticolosa e grandiosa. Il loro statuto indecifrabile e enigmatico conferma la loro essenza di segno indiziale muto, che ci porta al silenzio di Barthes: “niente da dire della fotografia”.
Il “Grande Vetro” “La mariée mise à nu par les célibataires, même”, l’opera principale di Duchamp, alla quale ha lavorato per dieci anni – dal 1913 fino alla sua ufficiale e dichiarata “non conclusione” nel 1923 – è di una complessità tale, che la sua discussione riempie libri e che, nonostante la quantità d’inchiostro colato, non può dirsi conclusa. Mi limito, quindi, a qualche spunto a sostegno del discorso, che interessa in questa sede.
Gli elementi fotografici nel “Grande Vetro” sono di tipo differente: strutturali, funzionali, fisici o materiali. Per cominciare il vetro stesso ricorda palesemente, la lastra del dagherrotipo e quindi i primi supporti della fotografia, oltre alla finestra, che funge da cornice per l’inquadratura della realtà. L’opera è divisa in due parti e comporta da un lato riproduzioni dipinte in modo iperrealista di oggetti industriali “già pronti”, dall’altro due tipi di tracce: forme dipinte con la polvere e forme rilevate da pezzi di stoffa mosse dal vento.
Le rappresentazioni iperrealiste degli oggetti industriali richiamano evidentemente l’indicalità dei ready-made e delle fotografie. La traduzione degli oggetti tridimensionali nel campo bidimensionale e la sospensione di essi nello spazio trasparente del vetro allude chiaramente alla fotografia. Il realismo della rappresentazione sottolinea lo stato di dipendenza dall’oggetto reale simile al principio fotografico.
I “Setacci”, le sette forme coniche nella parte inferiore del quadro, sono state dipinte con la polvere, che si era depositata sul vetro. La polvere ha lo statuto semiologico di traccia, e indica il tempo che è passato. La forma dei “tre Pistoni di corrente d’aria” – nella parte alta dell’opera – è stata stabilita sulla base di tre fotografie. Essi registravano tre volte la forma provocata dall’effetto del vento su un quadrato di garza sospeso davanti ad una finestra. I “Setacci” e i “Pistoni di corrente d’aria” sono, quindi, forme dipinte, che partono da tracce rilevate da procedimenti casuali, ma che sono stati indirizzati dall’artista: simile a una impostazione sperimentale, che provoca un risultato casuale.
La terminologia adoperata da Duchamp nelle note sul “Grande Vetro”, inserite nella “Scatola Verde”, ricorda da vicino il gergo fotografico (35): “Dati: 1) la caduta d’acqua, 2) il gas d’illuminazione, determineremo le condizioni del Riposo instantaneo: di una successione.. di fatti diversi.. per isolare il segno della concordanza tra.. questo Riposo e … una scelta di possibilità.” La “caduta d’acqua” allude all’atto di risciacquare la fotografia sviluppata, il “gas d’illuminazione” alla luce, che espone la carta fotografica. La “determinazione del riposo instantaneo” richiama alla determinazione della durata della “posa”, ossia dell’esposizione della carta fotografica alla luce. La “successione di fatti diversi per isolare il segno della concordanza tra il Riposo e una scelta di possibilità” potrebbe riferirsi alle varie combinazioni possibili tra tempo di esposizione e apertura della lente, oppure alla selezione del negativo da ingrandire, oppure ancora all’individuazione del soggetto da fotografare.
Anche nell’ultima pittura a olio “Tu m’” del 1918, considerata il pendant del “Grande Vetro”, si trova una sequenza di indici e tracce trasposte e fissate. Questa opera è un vero e proprio autoritratto artistico, un’accumulazione di elementi autoreferenziali, con rimandi alle opere precedenti dell’artista. Il quadro è composto da un lato da citazioni dipinte di ready-made, ottenute tramite proiezioni delle loro ombre. Dall’altro vi riappaiono i “3 Rammendi tipo”, “3 Stoppages Étalons”, propri dell’opera oggettuale precedente, avente lo stesso titolo. A destra del quadro essi si rifanno in forma di linee multicolori e a sinistra in forma dipinta più corposa. I “3 Rammendi tipo” riproducono l’andamento di tre pezzi di filo che, cadendo a terra si erano deformati “a loro piacimento” e di cui le forme ricavate sono state usate come modelli. In essi ritroviamo la stessa struttura indicale come già nei “Settacci” e nei “Pistoni” del “Grande Vetro”.
Al centro del quadro il rimando all’indice si fa ancora più esplicito: vi troviamo una mano dipinta che indica con l’indice. La mano è stata eseguita da un pittore di insegne pubblicitarie ed è quindi considerata da Duchamp come ready-made. L’atto di indicare stabilisce anche qui un rapporto tra il segno e un referente spaziale fisico. Come i “shifters” verbali “questo” o “quello”, anche la mano è un significante vuoto, che attende il suo compimento, tramite l’assegnazione di un referente.
Sulle speculazioni riguardo il significato del titolo dell’opera “Tu m’”, in cui qualcuno supponeva evidentemente che fosse “Tu m’emmerdes”, in italiano “mi infastidisci”, ciò che potrebbe essere stato indirizzato sia alla committente e collezionista Katherine Dreier, che al mondo dell’arte ufficiale in quanto tale, non vorrei esprimermi oltre. Questo, però, ci deve interessare rispetto al discorso dei “shifters”. Le parole “Tu m’” rimandano ai due commutatori “io” e “te”. Anche i pronomi personali sono segni verbali arbitrari, in cui il referente riempie lo spazio vuoto stabilito da un sistema di contiguità, che individua la presenza di un locutore. “Tu m’”, “tu a me”, ribadisce l’intervento di un punto di vista cangiante, di una prospettiva “shifting”.
Il gioco del “shifter” o l’anamorfosi dell’osservatore non si limita agli aspetti tecnici linguistici, ma trova la sua continuazione nei contenuti delle due opere: del “Grande Vetro” e di “Tu m’”. Entrambe sono degli autoritratti di un’identità doppia e ambigua, divisa tra io e te, tra il sé e l’altro, tra maschio e femmina. L’ambiguità tra Marcel Duchamp e il suo alter-ego femminile “Rrose Selavy” (detto “Eros c’est la vie”), trova qui il suo dispiegamento. Il “Grande Vetro” già è diviso fisicamente in due parti sovrastanti: in alto lo spazio della sposa e in basso quello dei celibi. “Mariée”, “MAR” e “iée” e “celibataires” “CEL” e “ibataires” contengono le sillabe “MAR” e “CEL” ovvero la parola “MARCEL”. Anche sulla copertina e la quarta di copertina dell’edizione di lusso della “Scatola Verde”, che contiene le note sul “Grande Vetro”, si trovano le iniziali dell’artista applicate. Le iniziali nella “Scatola Verde” e il gioco di parole nel “Grande Vetro” ci confermano la pista autobiografica, intesa qui come esperienza regressiva dell’lo, in uno stadio d’identità ancora iridescente, come autoreferenzialità eccessiva e forma di autismo: di fatti il “Grande Vetro” è considerato una elaborazione narrativa di un fantasma di masturbazione.
L’identificazione del ready-made e della fotografia come indice comporta un’altra conseguenza: l’indice si situa nel campo del presimbolico e preverbale, che richiama a una immediatezza corporea. Esso rimanda, quindi, a uno stadio di mutismo, che necessita un’aggiunta testuale, per elucidare il contenuto rappresentato. Il “Grande Vetro”, ad esempio, è stato accompagnato nel 1934, da note pubblicate nella “Scatola Verde”. Nonostante, come già spiegato in precedenza, queste note siano state formulate in uno stile criptico e anche se creano più confusione di quanto non chiariscano, funzionano pur sempre come didascalie e sottolineano il bisogno del segno indicale di un ulteriore specificazione verbale.
Già Walter Benjamin (36) puntava l’attenzione su questo aspetto, affermando che le fotografie nei magazines inibiscono per il loro carattere fuggevole la possibilità associativa del lettore e hanno bisogno di una didascalia, che includa l’immagine nell’ambito della letterarizzazione. Altrimenti la loro costruzione è destinata a rimanere approssimativa. La didascalia orienta l’osservatore in un percorso interpretativo e crea una sinergia tra parola e immagine. Essa ha, quindi, una funzione diversa del titolo di un’opera d’arte, che apre un ulteriore campo associativo e crea un senso terzo.
All’aspetto linguistico compete un ruolo fondamentale nella fotografia e nell’opera complessiva di Duchamp. Fotografie e ready-made sono segni di per sé, addirittura il genere più immediato: quello preverbale dell’indice. Per il loro carattere indicale e il loro punto di vista mobile questi oggetti necessitano un rapporto diretto con il referente, per acquisire un significato: esso dipende dal contesto in cui si trovano. Per il loro carattere muto esigono un complemento testuale, che inquadri il messaggio. Fotografia e ready-made sono, dunque, di per sé segni aperti, che permettono un gioco libero di associazioni e di rimandi linguistici e significativi. Entrambi possono essere considerati strumenti di scrittura con segni ancora indeterminati, in attesa di un compimento, da parte dell’osservatore che tesse la sua ragnatela di sensi intrecciati e illimitati. Ognuno vi può raccontare una storia “a suo piacimento”.
Il rapporto con la pittura
La preferenza duchampiana per il volgare e il banale ci porta a un ulteriore parallelismo con la fotografia. Essa è sempre stata ritenuta un sostituto di basso livello della pittura, perché considerata di facile uso e senza alcuna necessità di manualità tecnica precisa: “Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto”, suonava la prima pubblicità della Kodak del 1888. Franco Vaccari (37) esprime questo nesso in modo esplicito: se già per la fotografia si sospettava che non richiedesse di alcuna abilità – considerata criterio di garanzia dell’opera d’arte –, così anche il ready-made cadde sotto lo stesso sospetto: “Duchamp non costruisce e non esibisce nessuna abilità, si limita a scegliere gli oggetti anonimi dell’industria, senza traccia di lavoro”.
Nell’opera duchampiana, il riferimento al principio fotografico e alla sua scarsa manualità è, tuttavia, giocato consapevolmente come schieramento ironico nell’ambito del popolare, nel “bassoventre del corpo frigido della modernità”, come lo chiama Rosalind Krauss (38). Anche Roland Barthes (39) ha rilevato l’elemento del banale come problematica intrinseca alla fotografia: “Non è forse la debolezza stessa della fotografia, quella sua difficoltà ad esistere, che è chiamata la banalità?” L’utilizzo del “fotografico”, giocato come sinonimo del banale, rispecchia la critica duchampiana alla cultura cosiddetta “alta”, borghese, che l’artista considerava come presuntuosa e arrogante. La pittura, espressione paradigmatica di questo atteggiamento culturale, era disprezzata dall’artista come meramente “retinica” e come “olfattore”, per cui priva di senso e interesse.
Il dibattito sull’artisticità e sul rapporto con la pittura ha accompagnato la fotografia fin dagli esordi. Già Baudelaire diceva che la fotografia non era arte, perché troppo strettamente imparentata con il reale, ossia troppo lontana da un’interpretazione poetica dell’operatore. Se la leggenda vuole che la fotografia si sia impadronita del compito rappresentativo della pittura, copiando i suoi generi – quello del ritratto e del paesaggio –, in realtà il rapporto tra fotografia e pittura è caratterizzato da un complesso e continuo influenzarsi a vicenda. Il mito che la fotografia abbia liberato la pittura dal suo obbligo di raffigurazione e le abbia permesso di dedicarsi a pieno titolo alla ricerca formale pura, ad esempio nel Cubismo e nell’Astrattismo, non è esatto. In verità la pittura, già prima che la fotografia fosse inventata, aveva conseguito ricerche formali, riducendo l’oggetto e la sua rappresentazione sempre di più a essere un pretesto. André Malraux (40) formula questo pensiero: “fino all’Ottocento ogni opera d’arte era dapprima raffigurazione di un esistente o di un non-esistente. La pittura fu pittura pura soltanto per l’occhio dell’artista.”
Ciò che era già visibile in Turner, si è esplicitato nel “Mont de Sainte-Victoire” di Cezanne. Il fatto che il soggetto rimane lo stesso in una serie di quadri, evidenzia la predominanza della ricerca pittorica sul soggetto. Ancora Malraux: “Le montagne di Sainte-Victoire di Cezanne non evincono il peso poetico da ciò che è raffigurato, ma il raffigurato funge solo da pretesto per trovare una poetica propria.”
Tuttavia nemmeno la fotografia si è limitata a scopi puramente realistici. Già Fox Talbot – l’inventore del calotipo, della fotografia con il principio del negativo, nel 1839 –, ha isolato le forme che sfuggono all’occhio nudo. Anche i fotografi si sono interessati alla ricerca di immagini astratte e hanno in parte rifiutato il mimetismo descrittivo. D’altro canto, la pittura contemporanea non si è mai limitata alla ricerca formale e astratta, al contrario la pittura realistica è sopravvissuta, spingendosi in forme iperrealiste, creando raffigurazioni ancor più reali della fotografia. Anche nell’ambito dell’astrazione, la pittura ha approfittato della ricerca fotografica, ispirandosi all’interesse per il frammento, per l’inquadratura, per il piano avvicinato e per gli studi di movimento e gli effetti di luce.
Pittura e fotografia hanno inciso una sull’altra e l’entrata in scena della fotografia non ha fatto altro che spingere un’evoluzione già in corso nel campo dell’arte raffigurativa. Da tanto tempo la pittura non parlava di nient’altro che di pittura, attraverso la sua espressione materiale, limitando il soggetto a interesse formale. E la fotografia, anche quando sembra che parli del reale in quanto tale, in verità ha sempre parlato del rapporto con il reale, ossia della sua percezione. La fotografia e la pittura si incontrano laddove entrambe sono espressioni visive di un individuo e quindi scrittura e interpretazione formale, collegata alla percezione e a un punto di vista significante. L’evoluzione di ognuno dei due ambiti ha prodotto delle conseguenze reciproche, che hanno “fertilizzato” i due campi di indagine.
A questo punto viene da chiedersi, se veramente la fotografia e il ready-made possono, come ritiene Rosalind Krauss, essere ridotti al loro indiscusso carattere di indice o se non abbiano anche carattere iconico, come la pittura. Secondo Peirce l’icona si definisce tramite la sua somiglianza con il referente, un’icona sarebbe, quindi, una rappresentazione, con una grande percentuale interpretativa. È indubbiamente vero che la pittura può essere eseguita senza presenza necessaria dell’oggetto raffigurato, mentre sia la fotografia, sia il ready-made non possono esistere, senza la presenza del referente, di cui sono traccia diretta. Cercando, tuttavia, l’iconicità dal lato della lettura – e non soltanto da quello della produzione –, la situazione cambia. In effetti una fotografia non è una copia del reale, ma è soltanto simile a ciò che raffigura. Come la pittura, essa è traduzione da tre a due dimensioni, è inquadratura, è composizione. La stessa cosa si può dire del ready-made: esso assomiglia a se stesso, si autorappresenta, diventa immagine di se stesso dal momento in cui è stato scelto e incorniciato dallo spazio espositivo.
Thomas Zaunschirm (41) spiega il malinteso storicamente: “Nel 20º secolo, il ready-made è stato interpretato come qualche cosa che fosse priva di qualsiasi significato iconografico, ovvero come rappresentazione e simbolismo mancante.” Tuttavia, secondo Molderlings, citato da Zaunschirm, esso potrebbe, oltre allo statuto indicale e iconico, addiritura dimostrare carattere simbolico: “i ready-made incorporano in modo radicale il passaggio dall’immagine visiva pura all’immagine visiva del pensiero. L’oggetto è soltanto parte di un intreccio complesso di idee, a cui portano i giochi di parole e le espressioni letterari”. La relazione della rappresentazione con l’oggetto sarebbe allora, seguendo la definizione che Peirce dà del simbolo, sottomessa a una convenzione generale, come la relazione tra linguaggio e referente.
Il rapporto diretto con il reale di Baudelaire e lo statuto di indice e di impronta della fotografia e del ready-made di Rosalind Krauss, non sono argomenti sufficienti per escluderne completamente lo statuto di arte e di icona. Fotografia e ready-made sono nella loro struttura espressiva molto più vicini alla pittura, di quanto può sembrare a un primo sguardo. Essi si collocano nella scala estetica tra pura forma e mera rappresentazione, allo stesso titolo delle opere d’arte. Fotografia e ready-made contengono una porzione interpretativa ed espressiva, e quindi, di somiglianza e di iconocità, oltre a un valore simbolico, nonostante il loro rapporto immediato e istantaneo con un elemento preso in prestito dal reale. Una prova può essere la presenza massiccia di fotografie e di “oggetti trovati” nell’arte dei nostri giorni.
L’originalità e la riproducibilità
(…) (testo completo vedi pdf da scaricare)
Conclusione
Dai discorsi connessi alla fotografia e al ready-made sono apparse delle dicotomie, che potevano sembrare irrimediabilmente bloccate, nella loro complementarietà senza speranza. Il percorso svolto durante questa indagine non ha soltanto dimostrato che i fronti possono essere ammorbiditi e che le opposizioni possono essere sciolte, ma che gli elementi controversi costituiscono due lati della stessa medaglia e sono quindi connessi in un gioco interdipendente e mutuale. Le parti contrastanti si sono rivelate essere componenti intrinseche del meccanismo stesso, al cui funzionamento ciascuno contribuisce in una percentuale variabile, su una scala che porta da un estremo all’altro. Abbiamo visto come il reale e l’interpretazione, il caso e l’intenzionalità, l’artisticità e la tecnicità, l’originalità e la riproducibilità si integrano e si condizionano a vicenda in un movimento continuo di una macchina culturale, che produce senso e che scrive poesia. La fotografia e il ready-made si formulano su questi termini, che agiscono in maniera dialogica.
Vorrei allora tornare alla mia domanda iniziale: si può sostenere che la fotografia sia un ready-made e che il ready-made sia una fotografia?
Entrambi sono delle espressioni tipiche della modernità legate strettamente all’era dell’indistrializzazione e riflettono le problematiche della società di massa e della società dell’informazione. Senza l’avvento della riproducibilità tecnica nessuno dei due fenomeni sarebbe stato possibile e fotografia e ready-made non sono, infatti, ipotizzabili in un altro momento storico.
Nonostante la loro diversità nell’aspetto oggettuale e materiale, nel loro utilizzo e nella loro funzione sociale, nella loro collocazione storica e nella loro provenienza, dimostrano innegabilmente una stretta parentela e una similitudine palese nella produzione, nella struttura, negli elementi e nel rapporto con il linguaggio e con la pittura.
Concludendo risponderei insieme a Franco Vaccari (46) con una affermazione netta e ben definita: “ogni fotografia è un ready-made e ogni ready-made è una fotografia”.
Barbara Fässler 2006
(1) Susan Sontag, “Sulla fotografia”, Einaudi 1978. Orig. “On Photography”, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1973
(2) Charles Harrison, Paul Wood, “Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts”,Hatje Cantz Verlag, 2003 (traduzione Fässler)
(3) Thomas Zaunschirm, “Bereites Mädchen, Ready-made”, Ritter Verlag, Klagenfurt, 1983
(4) Claudio Marra, “Le idee della fotografia, la riflessione teorica dagli anni sessanta a oggi”, Paravia Bruno Mondadori Editore, 2001. Da: Marshal Mc Luhan, “Gli strumenti del comunicare”,
Il Saggiatore, Milano 1967. Orig. McGraw-Hill, New York 1964
(5) Claudio Marra, “Forse in una fotografia, teorie e poetiche fino al digitale”, CLUEB Bologna, 2002
(6) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and other modernist Myths”, MIT Press Paperback edition, 1986, citato da André Bazin, “What is Cinema”, University of California Press, 1967
(7) Susan Sontag, op. cit.
(8) Claudio Marra, “Le idee della fotografia”, op. cit. Da: “Il fotografico e il problema della rappresentazione”, in Fotologia n. 5, Firenze, 1986
(9) Rosalind Krauss, “Teoria e storia della fotografia, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, 1996.
Orig. “Le photographique”, Editions Macula, Paris, 1990
(10) Susan Sontag, op. cit.(
(11) Claudio Marra, “Forse in una fotografia”, op. cit.
(12) Susan Sontag, op. cit.
(13) Susan Sontag, op. cit.
(14) Thomas Zaunschirm, op. cit.
(15) Thomas Zaunschirm, op. cit.
(16) Roland Barthes, “La camera chiara, nota sulla fotografia”, Einaudi Editore, Torino, 1980. Orig.
“La chambre claire, note sur la photographie”, Cahiers du Cinéma, Editions Gallimard-Seuil, 1980
(17) Claudio Marra, “Le idee della fotografia”, op. cit. Da: Umberto Eco, “Di foto fatte sui muri”, in
“Il Verri”, n.4, Milano 1961
(18) Rosalind Krauss, “Teoria e storia della fotografia”, op. cit.
(19) Claudio Marra, “Le idee della fotografia”, op. cit. Da: Wim Wenders, “Una volta”, Edizione Socrates, Roma 1993. Orig. Verlag der Autoren, Francoforte, 1993
(20) Susan Sontag, op. cit.
(21) Rosalind Krauss, “Teoria e storia della fotografia”, op. cit.
(22) Franco Vaccari, “Fotografia e inconscio fotografico”, Agorà Editrice, 1994, 2. ed. 2006
(23) Walter Benjamin, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Ed. Einaudi, Torino, 2000. Orig. “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, Suhrkamp Verlag Frankfurt, 1955
(22) Franco Vaccari, “Fotografia e inconscio fotografico”, Agorà Editrice, 1994, 2. ed. 2006
(23) Walter Benjamin, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Ed. Einaudi, Torino, 2000. Orig. “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, Suhrkamp Verlag Frankfurt, 1955
(28) Franco Vaccari, op. cit.
(29) Ludwig Wittgenstein, “Philosophische Untersuchungen”, Bibliothek Suhrkamp, 2003 (traduzione Barbara Fässler)
(30) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths”, op. cit.
(traduzione Barbara Fässler)
(31) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths”, op. cit.
(32) Roland Barthes, op. cit.
(33) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths”, op. cit.
(34) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths”, op. cit.
(35) Rosalind Krauss, “Teoria e storia della fotografia”, op. cit.
(36) Walter Benjamin, op. cit.
(37) Franco Vaccari, op. cit.
(38) Rosalind Krauss, “Teoria e storia della fotografia”, op. cit.
(39) Roland Barthes, op. cit.
(40) André Malraux, “Das imaginäre Museum”, Campus Verlag, 1987. Orig. “Le musée imaginaire”, Albert Skira AG, Genève, 1947 (traduzione Barbara Fässler)
(41) Thomas Zaunschirm, op. cit. (traduzione Barbara Fässler)
(42) Walter Benjamin, op. cit.
(43) Claudio Marra, “Le idee della fotografia”, op. cit. Da: “Appunti per un’estetica della fotografia (1967), in intinerario estetico”, Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1987
(44) Roland Barthes, op. cit.
(45) Rosalind Krauss, “The Originality of the Avant-Garde and other Modernist Myths”, op. cit.
(46) Franco Vaccari, op. cit.